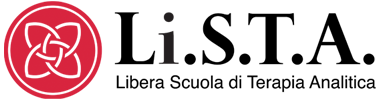“Violenza, alterità e amore” di Giulia Valerio

È arduo addentrarsi nel dominio della violenza, richiede cautela e buone protezioni, ma essa fa parte della storia collettiva come delle vicende personali, del recente secolo breve che ha conosciuto orrori sconosciuti e dei delitti perpetrati tra le mura domestiche.
Oggi abita i nostri mari e i nostri confini, che continuano a sanguinare. Terribile è la violenza che arriva dalla crudeltà dei nostri simili, ancora più feroce quella che arriva da chi è simile e prossimo.
Nel tempo attuale sperimentiamo gli abissi del male nei racconti dei nostri ospiti, di quanti hanno passato le arsure brucianti del deserto e gli spremitoi di carne umana dei campi in Libia, oppure le feroci barriere di confine della rotta balcanica.
Chi si impegna su queste soglie, da noi, è confrontato ogni giorno al grande male, ai sopravvissuti a un eccidio senza fine che interroga profondamente in noi sia la dimensione etica che quella religiosa. Non è facile sostenere lo sguardo di chi è sopravvissuto all’amico, al fratello, ai figli piccoli o in gestazione, al proprio consorte.
Di quanti hanno visto in volto, a occhio nudo, l’aspetto terribile di chi, invece di creare e guarire, soccorrere e accogliere, studia professionalmente come rompere il nocciolo segreto che tiene coesa una personalità, godendo del terrore, dello smembramento, del rovescio della medaglia della costruzione e della tutela dell’umanità.
Senza comprendere, i torturatori, che anche le loro notti diventeranno foreste d’incubi, che la vittima è penetrata in loro fino a stringerlo in un abbraccio a volte mortale o folle, perché
“in quanto individuo tu sei parte dell’umanità e partecipi all’insieme dell’umanità, come se tu stesso fossi l’umanità intera. Se sopraffai e uccidi il prossimo che si avvicina in te, allora uccidi quell’uomo anche dentro te, e tu hai assassinato una parte della tua vita. Lo spirito di questo morto ti seguirà impedendoti di gioire della tua vita” (1).
Eppure da queste soglie giungono anche testimoni che hanno tenuto intero il loro cuore attraversando l’orrore, il mysterium tremendum. Come Giobbe e come Cristo hanno compiuto la più alta prova iniziatica, quella che disordina corpo e mente per donare la conoscenza del bene e del male. Nel guado tra oscurità e chiarore si muove la coincidenza degli opposti, la capacità di tenere dentro, insieme alla violenza, anche la possibilità della sua composizione. Se tutto è polemos, come intuiva Eraclito, tutto è necessariamente anche eros, perché gli opposti si rovesciano uno nell’altro in un fluire continuo di scontri e di incontri. E l’amore è il più difficile dei sentimenti, il più irraggiungibile e tremendo, perché tiene dentro le parti nemiche impedendo di evacuarle e scaricarle sul nostro prossimo, (2) bombardando i territori dell’alterità rendendoli tanto invivibili quanto disperati.
Questi elementi si trovano in un antico mito dalla sorprendente attualità. Appoggiarsi alle antiche narrazioni protegge il nostro passato e noi stessi, orienta il presente e reinventa il futuro. Si tratta della vicenda che Eschilo narra nelle Danaidi, ‘trilogia legata’ composta da tre tragedie e un dramma satiresco, andata quasi interamente perduta: solo la prima, Le Supplici, è giunta a noi intatta (3).
Le protagoniste sono cinquanta giovani donne che fuggono dal loro paese d’origine, la Libia, perché minacciate da matrimonio forzato, imposto con la violenza dai cugini egiziani. Recano le insegne di un’inquietante diversità: esotiche cacciatrici scure di pelle, bruciate dal sole del Nilo, si profumano con sconosciuti balsami e acconciano i capelli con veli. Guidate dal padre Danao, stanno presso l’area sacra dove le statue lignee di Zeus salvatore e Apollo che ha conosciuto l’esilio, di Hermes araldo di libertà e Poseidone che ne ha scortato il viaggio. Gli dèi dell’agone e del rischio d’agonia ospitano nel loro temenos le cinquanta fuggitive, che recano bastoncelli con fiocchi di lana, segno di chi chiede protezione e asilo.
Sono approdate accanto a Lerna nell’Argolide, terra disseccata dall’ira di Poseidone, un tempo suo protettore. Cefiso Inaco e Asterion, i tre fiumi e numi tutelari del luogo, hanno corso il rischio di preferire Hera al dio dei flutti, segnando un destino. L’esperienza insegna che l’iscrizione in un archetipo costella un destino; non si sceglie a caso o per caso una via, un luogo, un soggetto di studio, un santo a cui votarsi: il nuovo nome apre un campo che a poco a poco ridisegna le mappe della nostra esistenza.
Hera sembra lontana da questa regione retta dai geni d’acqua, dall’abbondante fluidità, ma – come il mito disvela – solo in apparenza, e presto eserciterà la sua influenza. Un tempo vi regnava Foroneo, antenato degli uomini, figlio del fiume Inaco e di Melia, ninfa del frassino, grande albero che portava sulla chioma la fiamma di Zeus, la folgore. È suo figlio Foroneo il portatore sulla terra del fuoco divino, ceduto spontaneamente nello scambio ancora felice tra dèi ed umani
“prima che l’inganno sorprendesse lo slancio infaticabile di questo fuoco … e non sottratto agli dèi con l’astuzia né ottenuto con tecniche ripetibili” (4).
Fabbro molto lontano da Prometeo ed Efesto, non inventa armi da guerra per i mortali ma mette la sua arte al servizio di Hera, rivolgendole i primi culti amministrandone i sacrifici. Egli edificò la città di Argo radunando i dispersi e i nomadi nella prima forma sociale, che resse fondando il primo tribunale.
Il suo regno non descrive un’utopica età dell’oro né un impossibile paradiso perduto, ma il tempo in cui la relazione tra esseri umani e dèi non è ancora interrotta, in cui la congiunzione tra opposti – mistero tremendo della nostra civiltà – era l’armonia stessa dell’unione, della complementarietà, dell’incontro. Si tratta della lunga epoca storica che precede lo scontro tra uomini e donne, spesso dimenticato dalle nostre cosmogonie che iniziano con castrazioni, condanne all’inimicizia, soprusi. È il tempo cui presiedeva Hera, dea della congiunzione e della con-versazione, quando non era ancora solo la metà di Zeus e la rivale di tutte le amanti, ma la pienezza regale della parte femminile delle Nozze sacre.
Sullo sfondo della scena si scorgono Argo e il mare, porte d’ingresso delle realtà incombenti. Le vergini fuggono i figli di Egitto, fratello del padre, che bramano di possederle e sposarle nonostante il loro rifiuto. Hanno preferito l’esilio e la fuga, abbandonando la patria e affidandosi a mani straniere. Il nemico più feroce è a volte il più prossimo, anche se spesso si cerca di proiettarlo altrove, sviando la paura del contatto e la minaccia vicina. Gli accenti con cui li descrivono sono pieni d’odio e colpiscono per la modernità di linguaggio:
“per innata avversione contro ogni maschio/ detestiamo le nozze dei figli d’Egitto/ e la loro perversa libidine …; folle foia li travolge, pungiglione non rintuzzabile; chi si unirebbe a parenti per farsene dei padroni?; Oh ma io non cada mai sotto il dominio/ della mano dei maschi!” (5).
Le Danaidi hanno il coraggio della fuga e della spietata denuncia della brutalità dei cugini, ma accanto all’odio e al risentimento proclamano, per le nozze, il diritto al proprio sentimento. La violenza non è soltanto stupro e offesa del corpo, ma costringe il cuore a dilaniarsi, a subire un giogo non voluto. Ai violenti eccitati cugini augurano la morte, che un uragano li affoghi nel loro inseguimento, perché su una nave veloce le stanno raggiungendo. Giunge in quel mentre il re della città con il suo corteo, cui rivolgono le loro suppliche: il venerando Pelasgo è pronto ad accogliere chi è appena sbarcato e ne chiede la provenienza. Vengono dalla lontana – oggi così prossima – Libia, di cui il loro padre è re. Sono (allora come oggi) rifugiate che chiedono asilo politico, perché a rischio di morte. Se inascoltate, un miasma inonderà la città: non si possono offendere gli déi.
L’ospite che arriva attraversando il nostro mare è ricco della sua storia tragica e sfonda i confini, bussa alle porte, interroga la nostra vita. Perché rischia la vita, e si presenta carico di una minaccia di morte: non la nostra, la sua. L’eterno Arrivante costella il regno gratuito e sacro dell’ospitalità, che da sempre ha leggi antiche e regge migrazioni e pellegrinaggi, sfollamenti e diaspore, forse tutta l’erranza che è la vita stessa. Le sue leggi non possono essere infrante: chi chiude la propria porta al Dio travestito verrà colpito da un’epidemia che è condanna alla sterilità della stirpe, a guerre fratricide, a contagi e malattie.
L’ospite inatteso e indesiderato risveglia ogni violenza sopita, ne è bersaglio proiettivo privilegiato perché spaventa e incute terrore: nei racconti e nelle fiabe è vestito dei panni di Dio, è numinoso e potente anche se il più delle volte si presenta come mendico, povero, straccione. Rappresenta ciò che non vogliamo riconoscere né accogliere in noi stessi: è la funzione che fa crollare l’intero edificio, la pietra di scarto su cui non si possono fondare imperi ma solo percorsi individuativi, che percorrono i margini della collettività e non i suoi palazzi.
Le preghiere rivolte a Pelasgo conoscono argomenti molto persuasivi. Le Danaidi sono barbare ma anche consanguinee, straniere e concittadine. Rivendicano antenati comuni perché discendono da Io amata da Zeus, splendida fanciulla argiva che venne tramutata in giovenca dalla gelosia di Hera; perseguitata da un ‘pungiglione non rintuzzabile’ fu costretta ad errare di costa in costa lungo il Mediterraneo, inseguita dall’assillo di un tafano divino, finché giunta in Egitto Zeus con un lieve tocco la placò e la fece tornare donna, generando Epafo, loro progenitore. Nella loro genealogia è iscritta anche la possibilità eversiva che l’amore possa compiersi con gesto tenero e felice, soffio e carezza, “violenza dolcissima” (6).
Se non verranno accolte, minacciano la più grave contaminazione: sciogliendo le cinture delle vesti si impiccheranno sulle statue sacre, chiedendo protezione allo Zeus d’oltretomba, il più ospitale tra tutti gli dèi. Alle nozze preferiscono Ade, sposo prediletto di molte fanciulle del mito, che ben sanno che nell’incontro d’amore con l’Altro si spalanca la voragine del mistero e dell’inconoscibile, poiché si consuma lo strappo dalla matrice originaria, il distacco dal proprio alveo. Così Pelasgo si trova a esitare tra due mali terribili: lo sdegno divino e la guerra certa con gli Egizi, al loro sbarco.
Come i saggi sanno fare, ammette di essere incerto e di avere paura, poiché senza dolore non vi è mai esito possibile. Egli vuole consultare il suo popolo e decidere in assemblea, con scandalo delle Danaidi che desidererebbero un atteggiamento più deciso e unilaterale: gli ricordano di essere sovrano e sacerdote e di poter, da solo, rappresentare il popolo. Eschilo qui tratteggia con straordinaria finezza il carattere delle vergini: irretite dal complesso paterno, sono esempio patente di come esso agisca sulla figlia, rendendola ricca di ideali, devota al principio maschile fino alla dismisura, ma incapace di amore e di incontro con l’Altro, sempre vissuto come tradimento e caduta. Le Danaidi sono preda di passioni violente, presente passato e futuro sono istantaneamente attivati in loro e non lasciano spazio alla speranza, al dipanare i sentimenti in un tempo disteso, al fronein cui le invita il padre. A questo si sommano il panico, lo sradicamento dalla terra, il terrore, emozioni aumentate e alimentate dalla potenza del complesso.
A tale tirannia della figura paterna (sempre un po’ monarchica) fa fronte il governo di Pelasgo: per descriverlo occorre per la prima volta nella letteratura la parola ‘democrazia’. Gli Argivi con alzata di mano ‘decretano’ (altro neologismo coniato da Eschilo) di accogliere le supplici, pronti a difenderle con le armi. Subito irrompono dal mare gli Egizi, per le Danaidi stirpe esiziale e furibonda, mai sazia di sangue. La guerra tra uomini e donne è crudele, abitata dall’odio e dalla violenza: i pretendenti le considerano prede, sordi alle voci di dèi che non li hanno generati; sono bestiali nei loro appetiti e le possederanno trascinandole per i capelli sulla nave, le marchieranno a fuoco e faranno scorrere fiumi di sangue. Dopo tali minacce pronunciate da un araldo (probabilmente nella recitazione della tragedia si trattava dello stesso attore che impersonava Danao, sapiente notazione che non lascia indifferenti), gli Egizi stanno per passare all’atto. Pelasgo, arrivato con l’esercito, vuole trattare con gli invasori: non si dice contrario per principio alle nozze, se le fanciulle acconsentono convinte con parole giuste e probe, non trascinate da bruta violenza.
Ogni offerta di mediazione è vana, e le straniere vengono rifugiate nelle case di Argo. Prima di congedarsi, il padre le esorta al pudore, a rimanere fedeli al voto di castità stretto tra loro, che devono avere più caro della vita stessa. Danao ha da sempre legato a sé le figlie, marcandone il destino; esse sono diventate ferocemente avverse ad ogni forma di matrimonio, che augurano come maledizione ai nemici. Le loro ancelle cercano di temperarne gli sdegni, invocando Hera e Afrodite e invitandole con lungimirante sapienza a non rifiutare quello che viene dagli dèi, che non hanno voluto ostacolare con vento contrario il viaggio dei pretendenti. La prima tragedia si chiude con una triplice invocazione a Zeus, che le “liberi da nozze atroci con sposo aborrito”.
La seconda tragedia, gli Egizi, è dedicata all’inarrestabile vittoria degli stranieri, che si insediano e prendono il comando della città. Nessuno potrà più salvare le cugine dal matrimonio esecrato. La loro paura diviene furia vendicatrice e omicida: il padre, con l’approvazione degli Argivi, le invita a festeggiare le nozze, a rendere ebbri gli sposi e a decapitarli dopo il banchetto, prima che si compia l’unione. Al mattino attende, distese ai suoi piedi, le cinquanta teste dei generi.
L’ultima tragedia, le Danaidi, contiene l’inaspettata lysis della vicenda: nell’alba fatale vi sono solo quarantanove prove degli assassini compiuti. Una delle figlie, Ipermnestra, ha disobbedito al comando del padre, sorpresa da amore per lo sposo, forse il meno tracotante, il meno ubristes dei fratelli. Così sospende la mano armata e lo aiuta a fuggire, stabilendo tra loro un accordo segreto: alla fine delle loro peripezie accenderanno una fiaccola in alto sulle colline, per segnalare la loro reciproca salvezza.
Ad Argo per lungo tempo nella festa delle torce
“si commemorano i segnali di fuoco scambiati tra Linceo e Ipermnestra, prima coppia umana che aveva rifiutato la violenza sessuale e assassina per inaugurare il tempo del potere condiviso e dei diritti della sposa sul letto coniugale. Argo in festa è illuminata dalla fiamma di un messaggio amoroso” (7).
Il nemico si spoglia di violenza e diviene un amante; la vergine stravolge la sua furia in grazia e tenerezza, e la tensione assassina di entrambi si disarma.
Ma il gesto mancato della figlia è anche grave delitto, atto di disobbedienza alle leggi paterne, assai pericoloso perché permette a un nemico di sopravvivere alla strage, di diventarne il potenziale vendicatore. Per la sua insubordinazione Ipermnestra viene imprigionata e tradotta davanti al tribunale di Argo. Come Apollo ed Atena sono scesi dall’Olimpo per discolpare Oreste accusato di matricidio, Afrodite entra nel tribunale come avvocata dI Ipemnestra per difendere l’amore, forza sovversiva e divina. Un lacerto della sua perorazione giunge a noi dai Papiri di Ossirinco, tessera di un magnifico mosaico di rivoluzione:
Ama il Cielo sacro penetrare la Terra/ e amore di nozze afferra la terra:/ acqua copiosa cade dal Cielo di pioggia/ e feconda la terra generando ai mortali/ i pascoli per le greggi e le messi di Demetra/ che vivifica, e le piante ormai mature;/ ecco il frutto complesso delle umide nozze,/ da cui tutto si compie./ Di questo io sono la causa./ Di questo io sono Signora (8).
Il tribunale assolve Ipermnestra, decretando il diritto di scegliere liberamente lo sposo da parte della donna, al di là della legge del padre e dell’oikos, della definizione di cittadinanza e della discendenza legittima. Per gratitudine la nuova sposa consacra nel luogo del giudizio due statue, una ad Afrodite e una ad Hermes, gli dèi che ispirano le parole della notte e presiedono allo scambio di piaceri reciproci, ed in noi custodiscono l’ermafrodito, archetipo delle nozze sacre.
Il dramma satiresco Amimone che conclude la trilogia narra che in realtà le teste decapitate ai piedi di Danao non erano quarantanove ma quarantotto, ancora una in meno. Un’altra sorella si era staccata fin dall’inizio della vicenda dal coro delle supplici, seguendo un differente destino. Appena sbarcata Amimone l’impeccabile, con i suoi cani da caccia, va in cerca di una sorgente nell’arida terra di Argo. Le acque purificano gli altari, e la ricerca della sorgente è atto fondativo, inaugurale “per prendere possesso della terra e radicare questa stirpe violenta e violentata”, perché chi migra è spinto da dolore. Sono cacciatrici, le figlie di Danao, ma anche idrofore, portatrici delle brocche durante i sacrifici d’acqua, fluido che connota la fertilità e la vita e ad un tempo la preparazione delle vittime: “purificatrice, è anche l’acqua d’angoscia in cui si riflette il coltello, l’acqua evocatrice del sangue dello sgozzamento” (9). La loro è storia di sangue e d’acqua, flussi di vita.
Come accade in molti miti di fondazione, i cani tornano a lei con le zampette bagnate, perché hanno trovato la sorgente. Presa dall’affanno della corsa, la fanciulla inciampa ridestando un Satiro addormentato: ha tratti umanoidi e cavallini che segnano la dismisura del suo appetito sessuale, e scorgendola viene colto da bramosia. Lì accanto dorme il dio non più prescelto, che per orgoglio ferito e per vendetta ha disseccato la sua terra: Poseidone si ridesta nel sentire le grida disperate della Danaide, accorre in soccorso e la salva, mettendo in fuga il violentatore.
Ma anch’egli, il dio delle acque profonde, viene preso da amore per lei; a poco a poco la conforta e inizia con dolci parole a corteggiarla, a persuaderla, a invitarla all’amore. Alla tenerezza segue la promessa di un’alleanza tutta nuova in cui la libera scelta reciproca, simmetrica, viene sancita per sempre. Anche queste nozze richiedono un segno di gratitudine, come le statue erette da Ipermnestra: Poseidone batte col tridente la roccia, facendo sgorgare le acque di Lerna, alimentate in tutte le stagioni da una sorgente sotterranea. Nel cuore della città Poseidone apre la sorgente Amimone e la consacra ad Hera, di cui Ipermnestra sarà la prima sacerdotessa. Termina con questo prodigio ogni inimicizia, aprendo un tempo di pace anche tra divinità rivali.
Duemilacinquecento anni fa Eschilo, iniziato ai misteri eleusini, racconta di migrazioni, di rifugiati, di unioni forzate, di richieste di protezione umanitaria, di conflitti tra leggi assolute e leggi democratiche, dell’impossibile giustizia umana, di parità di diritti tra generi, di libertà d’amore, di necessità di interrompere rivendicazioni, muri e difese, perché le sacre leggi della vita vanno sempre rispettate e onorate. Dal punto di vista dello ‘spirito del profondo’, narra le vicende dei complessi edipici, della brutalità delle proiezioni inconsce, del mysterium conunctionis e delle nozze sacre, della potenza degli archetipi, del principium individuationis. E ricorda che soltanto se sospendiamo ogni scelta unilaterale e il diritto a dare la morte, soltanto se la violenza viene conchiusa nel vaso alchemico interiore, lasciata decantare e poi compresa, soltanto allora l’Altro, che Ipermnestra e Poseidone non annientano, può disarmare la storia e inventare un tempo dove viene inventato l’aggettivo ‘nostro’, il nostro comune futuro.
Giulia Valerio, aprile 2018
[1] C. G. Jung, Il libro Rosso. Liber novus, Bollati Boringhieri, Torino 2010, p. 254.
[2] C.G. Jung, Il libro Rosso., pp. 235 e 239-240.
[3] Parte di questo studio è pubblicata in inglese in, Myths, migrants and movements of the soul, Guild papers n°328, London 2018.
[4] M. Detienne, Les Danaides entre elles. Une violence fondatrice du mariage, in L’écriture d’Orphée, Gallimard, Paris 1989, p. 48.
[5] La traduzione è di C. Carena in Eschilo, Le tragedie, a cura di C. Carena, Einaudi, Torino 1956.
[6] Le supplici, op. cit., Esodo, Ant. IV.
[7] M. Detienne, op. cit., p. 51
[8] Papiro di Ossirinco, POxy (1952) 2255 fr. 14 in Eschilo. Tutti i frammenti con la prima traduzione degli scoli antichi, a cura di I. Ramelli, Bompiani, Milano 2009, frag. 125, pp. 250-251 e R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi, Milano 1988, p. 85.
[9] M. Detienne, op. cit., pp. 51-52.